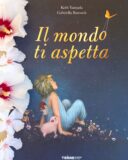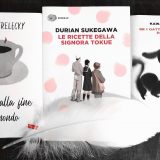LETTERE DALLA GRAFIA FEMMINILE: Stefan Zweig e Franz Werfel

Lettera di una sconosciuta di Stefan Zweig e Una scrittura femminile azzurro pallido di Franz Werfel: due opere ambientate a Vienna a distanza di poco più di un decennio, incentrate sulla ricezione da parte di un uomo di una lettera scritta da una donna…
Una «grafia femminile affannosa e sconosciuta»
Opera del 1922, Lettera di una sconosciuta è un condensato d’enfasi e intensità, comune denominatore di altre opere di Stefan Zweig, con la loro capacità introspettiva, il loro scavare nella psiche e nelle passioni umane – è nota, del resto, l’influenza del connazionale Freud, di cui Zweig ha scritto anche una biografia.
Pur ascrivibile al genere epistolare, Lettera di una sconosciuta è un monologo che non concede possibilità di scambio, di risposta. È un lascito accorato, lacerante. La febbrile confessione a posteriori di un amore sempre taciuto, struggente, come forse solo gli amori non contraccambiati sanno essere. Febbrile in senso stretto e in senso lato.
A te, che mai mi hai conosciuta: l’intestazione della lettera che un celebre scrittore viennese trova tra la posta già colpisce. E l’incipit del manoscritto è di pari impatto: «ieri il mio bambino è morto», è, infatti, la frase che dalla prima riga ricorrerà più volte, come una litania. L’ignota continua: «Mi sei rimasto solo tu, tu che mai mi hai conosciuta e che io ho sempre amato».
La lunga lettera non ha fini, se non lo svelamento di ciò che non è stato mai svelato. È un testamento immateriale, un addio. Se l’uomo la sta leggendo, vuol dire che anche la scrivente, come il figlio, è deceduta: «…se ora la tieni in mano», gli spiega, «sappi che […] una morta ti sta raccontando la sua vita, quella vita che fu tua» e «di cui tu non hai mai saputo nulla». Una vita che ha avuto un vero inizio soltanto il giorno in cui lo scrittore vi è entrato, una quindicina di anni prima.
La donna aveva tredici anni quando il romanziere si è trasferito nell’appartamento di fronte. Da quel momento, lo sconosciuto scrittore costituirà il suo unico interesse, il suo intero mondo, e per anni l’esistenza dell’ignota consisterà nello spiarlo. La lettera ci offre pagine ardenti di momenti per lei indelebili nella memoria, quali il primo sguardo che l’uomo ha posato su di lei, o la prima volta in cui ha avuto fugace accesso al suo appartamento. Minimi contatti ed episodi – «puerili follie»– di cui gli amori adolescenziali si nutrono e s’inebriano, rivissuti in futuro all’infinito.
Persino trasferitasi altrove, l’ignota non fa che alimentare il sentimento, con una volontà che sfocia nell’ostinazione, rasentando il fanatismo, come riassume bene la frase «non dovevo lasciarmi distrarre dalla mia passione, da quel voler vivere soltanto in te», quasi che quell’amore fosse sacro e lasciarlo anche solo affievolirsi un inconcepibile sacrilegio.
A distanza di qualche anno, l’ossessione porterà l’anonima ad avere alfine accesso al «paese incantato», all’«antro di Aladino»; «ogni cosa, ogni cosa si avver[a]». Per lei, nonostante la cocente delusione di non essere riconosciuta dallo scrittore, è la «volontà fattasi parola, il desiderio di mille singoli giorni che irromp[e] tutto assieme». Ed è come se la ricerca del suo personale santo Graal trovasse in qualche modo compimento.
Non solo: germina un frutto, di cui l’anonima non paleserà mai al padre l’esistenza, e che per lei diventa tutto. Negli anni avrà contatti con il romanziere altre volte, senza che lui mai la riconosca. E non soltanto seguiterà a non inquadrarla, ma in un’occasione la scambierà, addirittura, per una sgualdrina.
(Non) essere per chi per noi è tutto
Dopo un breve sfogo, subito mitigato, sentendo le forze abbandonarla, con un «è stato bello, nonostante tutto», la sconosciuta si avvia a concludere la lettera. La consola il pensiero che la sua morte non toccherà lo scrittore. Non gli lascia né il suo nome né altro. Solo una cosa gli chiede: che, ogni anno, nel giorno del proprio compleanno, il romanziere acquisti delle rose bianche, per supplire a quelle che lei, in quella data, non mancava di inviargli, cosicché il «lieve soffio della [sua] vita» intorno a lui non si disperda del tutto.
Ed è per l’appunto nel giorno del suo compleanno che il romanziere riceve la lettera-testamento. L’ultima immagine è proprio quella del vaso delle rose, per la prima volta vuoto.
La lettera è un grido di dolore, per non essere mai stata riconosciuta. Ed è un mezzo per esistere, proprio quando fisicamente l’autrice non esiste più. Esistere nella coscienza dello scrittore, come non ha mai fatto in vita.
Per chi fosse interessato, ho scritto di questa intensa opera di Zweig anche in L’amore come annullamento di sé: Sándor Márai, Stefan Zweig e Madeleine Bourdouxhe.
Una «ripida e severa calligrafia femminile»
In Una scrittura femminile azzurro pallido di Franz Werfel il punto di vista non è quello della mittente, bensì del ricevente, l’alto funzionario ministeriale Leonida. E, oltre allo scandaglio psicologico che accomuna questo breve romanzo a Lettera di una sconosciuta, troviamo in Una scrittura femminile azzurro pallido anche un’analisi sociale della Mitteleuropa di quel particolare momento storico.
Da «un nessuno» qual era, grazie a un’impensata, insolita e fortuita eredità, a Leonida si spalancano le porte dell’alta Vienna; diviene uno dei giovani più ambiti e finisce per scalare i vertici sociali, tramite il matrimonio con la facoltosa Amelie Paradini.
Ma se Amelie costituisce «il grande, grandissimo successo della sua vita», il vero amore di Leonida è stato Vera Wormser, proprio la mittente della lettera. La conoscenza tra Vera e Leonida risale all’epoca in cui lei era all’incirca quindicenne e lui indigente precettore del fratello. Al tempo Leonida amava disperatamente Vera, sentendosi però «disprezzato da tutti e deriso da qualsiasi donna».
Leonida rincontra Vera anni dopo, quando, già affermato, riesce a presentarsi «come un gran signore agli occhi della fanciulla un tempo adorata». I due trascorrono sei settimane d’amore, che Leonida definisce «l’autentico matrimonio della [sua] esistenza». Illude Vera di una futura vita coniugale insieme, non rivelandole che è già sposato, per poi sparire nel nulla. Vera lo cerca un’unica volta, tre anni dopo, inviandogli una prima lettera, che Leonida non apre. Trascorsi altri quindici anni, ecco d’un tratto comparirne una seconda.
Scritta in modo del tutto formale, quest’ultima missiva si presenta come innocua. E tuttavia Leonida vi ravvisa la velata rivelazione dell’esistenza di un figlio comune e definisce la lettera «diabolica», «la più perfida al mondo», uno «scritto biecamente calibrato».
Proprio quando Vera sembrava «essersi dissolta perfettamente nel nulla», l’impeccabile realtà di cristallo dell’alto funzionario pare destinata a incrinarsi: «i fondamenti sicuri della sua esistenza appa[iono] sovvertiti».
Scoprirà la verità, e noi con lui, nel doppio colpo di scena verso il finale.
Due diversi ignorare
Sia in Lettera di una sconosciuta sia in Una scrittura femminile azzurro pallido ci troviamo di fronte a due personaggi maschili cui la fortuna ha arriso. Riguardo a Leonida, emblematica è la sua percezione di «essere un vero e proprio pupillo degli dèi». Del resto, è «uno di quei quaranta o cinquanta funzionari su cui in effetti si reggeva lo Stato» e «nella sua posizione uno è un po’ come Dio».
Entrambi questi due uomini, nelle loro vite dorate, ignorano. Il romanziere di Lettera a una sconosciuta nel senso che non sa, è all’oscuro dell’amore ardente di cui è oggetto, della donna che a lui vota la vita, sciupandola nell’ombra, nonché di essere padre di un bambino. E non può che destare una certa incredulità che non riconosca mai la sconosciuta, pur intrattenendosi intimamente con lei più di una volta.
Quanto a Leonida, sceglie volutamente di distogliere lo sguardo e trascurare le proprie responsabilità. Decide, infatti, di ignorare la prima lettera di Vera e vorrebbe fare altrettanto con la seconda, in virtù del principio secondo cui «se uno non sa nulla, non può essere chiamato a rispondere di nulla».
Leonida ha, inoltre, sempre avuto il presentimento di avere un figlio con Vera, ma, forte del fatto che l’amante, a parte quella prima lettera, si è poi ritirata dalla scena, ha sempre portato avanti la propria esistenza imperturbata.
La consapevolezza di essere il padre di un giovane sconosciuto non gli piombò addosso come dal nulla, non lo colse del tutto di sorpresa. Nella zona crepuscolare della sua coscienza, del suo senso di colpa, della sua angoscia e della sua curiosità, il figlio di Vera viveva in lui un’esistenza minacciosa fin dal giorno sconosciuto in cui era nato.
Un personaggio con (ben poche) luci e (molte) ombre
Leonida emerge, del resto, come una figura non priva di rimorsi, ma pavida e vigliacca, incapace di redimersi e rinunciare al proprio «fulgido Olimpo». Il suo rovello interiore, l’altalenanza tra auto-accusa e auto-giustificazione si dipanano lungo l’intera opera, e il dialogo con la sua coscienza ha un ruolo del tutto centrale.
Da una parte Leonida è ben conscio delle sue colpe, tanto che, in un lungo soliloquio, figurandosi come imputato dinnanzi a una corte di giustizia, ammette di essersi comportato nei confronti di Vera «come un finto cavaliere che prende le donne con insidiosi lacci, come un volgare istrione che elargisce illusioni matrimoniali», e usa termini come «delitto» e «mala fede». E oltre al giudizio terreno, ricorre più volte il tema di quello Universale. Ciò nonostante, non manca di trovare vili attenuanti.
Se da una parte Leonida dice di aver stimato Vera per aver accettato la sua scomparsa ed essersi eclissata, nei due momenti della vita in cui riceve da lei uno scritto si sente come defraudato del proprio presunto diritto alla tranquillità. Sottolinea la perfidia di Vera e non risparmia allusioni all’influsso che, secondo lui, l’essere ebrea dell’ex amante determina sulle ingerenze della donna – un certo antisemitismo da parte di Leonida emerge a più riprese.
Tutto era ormai superato, tutto sistemato nel migliore dei modi. Lui l’aveva apprezzata moltissimo per la sua comprensione, per essersi così bene adattata all’inevitabile. E ora questa lettera! […] Leonida pensa seccato: Vera in definitiva non è alto che «un’intellettuale israelita».
È mio inalienabile diritto acquisito che essa non ci sia più. È inaudito da parte di questa donna che ancora una volta mi metta sotto il naso il fatto di esistere.
L’alto funzionario pare a un certo punto risolversi ad «affrontare la verità e rinnovare la propria esistenza». Ma accade poi l’impensabile: non solo fruga tra le cose della consorte sperando di trovare prove di un’eventuale infedeltà di Amelie, che attenuerebbero la sua colpa, ma neanche di fronte alla confessione della moglie di aver nutrito orribili sospetti, trova il coraggio di svelarsi.
Da rimarcare è anche l’emergere del tema del doppelgänger. Sulla panchina di un parco, Leonida incontra un uomo che pur avendo all’incirca la sua età è un vecchio relitto: quell’uomo rappresenta «il fratello gemello, l’altra possibilità della sua vita, quella a cui solo per un pelo si era sottratto». E Leonida stesso si chiede in virtù di cosa a lui sia stato risparmiato un simile sfacelo. Per poi lanciarsi, però, nel finale in un’apologia di se stesso, delle difficoltà affrontate e superate, dei propri meriti.
Nella fosca chiusura – anche il tempo atmosferico durante la giornata è parso riflettere un declino –, in contrasto con lo sfavillante consesso di elitari riuniti a teatro, Leonida pare introiettare la rovina del doppio. E sa perfettamente che ogni salvezza è persa.
Due donne senza pretese
Quanto a Vera, fino all’incontro con Leonida non la vediamo che attraverso i ricordi e i pensieri del protagonista, ma già dalla descrizione della calligrafia s’intuisce il carattere di questa donna, così diverso da quello della scrivente di Lettera di una sconosciuta.
La forza di Vera si materializza per Leonida perfino a distanza, nel momento in cui, volendo stracciare la lettera, l’uomo la apre senza volerlo:
Soltanto la forza di Vera lo aveva costretto a leggere la lettera che altrimenti avrebbe strappato per sottrarsi ancora una volta alla verità.
Emergono rigidità, asprezza, orgoglio e distacco da Leonida, il ricorrere a lui soltanto in quanto costretta, il rivelare certi segreti a malincuore. Leonida stesso afferma di questa donna che «era affiorata come uno spettro per poi dileguarsi una volta per tutte dal suo senso di colpa, seria, nobile, senza alcuna pretesa».
La mancanza di pretese accomuna Vera alla sconosciuta di Zweig, la quale, tuttavia, si è al contrario strutta nel proprio sentimento, consacrando la vita a colui che l’ha ignorata, senza mai voler recidere il legame, neanche dopo la morte.
Posta, compleanni e rose
Lettere, figli, donne senza pretese, figure maschili poco fulgide e non solo. In entrambe le opere la narrazione prende le mosse dalla ricezione della posta. Entrambi i protagonisti ricevono le lettere in occasione del loro compleanno. In ambedue i racconti assumono un significato simbolico le rose: mentre in Zweig vogliono farsi traccia di un residuo di vita, rendendo l’amore perpetuo, ed è la loro assenza a trasmettere un senso di morte, in Werfel vengono associate unicamente a quest’ultima.
Riguardo ai due autori, entrambi di origini ebraiche, li accomunano il vedere le loro opere bruciate dai nazisti e la successiva condizione di esiliati. Zweig si suicidò proprio nel 1941, anno di pubblicazione di Una scrittura femminile azzurro pallido.